
“La teoria gerarchica dell’intelligenza”
La teoria unitaria dell’intelligenza, riferibile alla teoria del fattore ‘g’ e a un uso non decomposto del Quoziente d’Intelligenza, incontra molti problemi e in particolare si dimostra incapace di spiegare le diversità delle menti, i deficit specifici, le scarse correlazioni fra differenti prove cognitive. E’ quindi necessario riconoscere che la mente è articolata in diverse funzioni.
Tuttavia tanto la teoria modulare, quanto la teoria delle intelligenze multiple sono oggi ritenute da molti psicologi cognitivi eccessivamente radicali, sia perché non riconoscono le relazioni fra diverse operazioni mentali, sia perché portano alla conseguenza poco sostenibile per cui tutte le operazioni della mente sarebbero su uno stesso piano di centralità di funzionamento intellettivo.
Va invece osservato che una persona priva di capacità di ragionamento logico (come accade nelle disabilità intellettive gravi) incontrerà difficoltà in gran parte delle sfide, piccole e grandi, propostegli dalla vita e questo indipendentemente dal fatto di vivere in una società o in un’altra. Al contrario, la perdita o la carenza di altre forme di intelligenza specifica non implicano problemi generali di adattamento.
Una conciliazione fra una teoria multipla delle intelligenze e il riconoscimento che esse sono relate e di diversa importanza è rappresentata dal modello a cono descritto in figura 1 (Cornoldi, 2007) ove le varie forme dell’intelligenza sono pensate come distribuite, senza soluzioni di continuità, in un cono che ha ai vertici le abilità che richiedono il controllo massimo e, alla base, le abilità che implicano la maggiore specificità e il minore coinvolgimento delle strutture intellettive centrali. Alla base, ove l’esperienza conta in modo massiccio, essendo le abilità altamente specifiche, vi è una forte diversificazione fra abilità che riguardano contenuti differenti: il linguaggio, la visualizzazione, i numeri, ecc.. Questa specificità si riduce invece verso i vertici del cono che risultano d’altra parte sensibili ai fattori che influenzano il controllo mentale, come le emozioni e gli stati di consapevolezza metacognitiva.
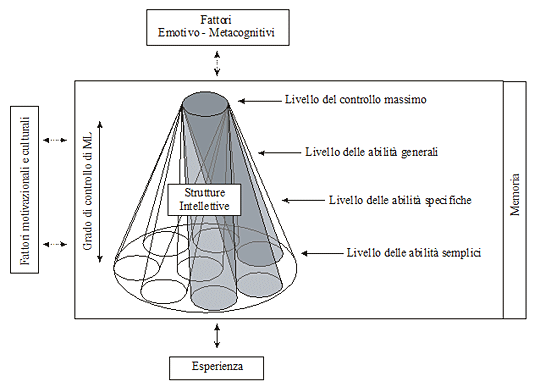
La teoria gerarchica dell’intelligenza applicata ai disturbi dell’apprendimento
Abbiamo già osservato che il bambino che non riesce a leggere, ma capisce bene quello che gli viene letto, è privo di una competenza che non sembra compromettere il funzionamento intellettivo e che è altamente specifica: la lettura strumentale (e il suo disturbo) possono quindi essere collocati al livello basso del cono, nell’ambito delle abilità specifiche. Tuttavia già è diverso il caso di un bambino che sa leggere, ma fatica a capire quello che legge. Siamo ancora nell’ambito delle abilità che hanno una specificità di contenuto (riguardano prevalentemente il linguaggio), ma le operazioni intellettive richieste hanno un carattere più generale (bisogna riconoscere il significato delle parole, delle frasi, delle relazioni fra le frasi; occorre crearsi una rappresentazione del significato trasmesso dal testo, ecc.). Una difficoltà di comprensione del testo si colloca dunque dalla stessa parte di una difficoltà di lettura tecnica, ma in un punto più elevato del cono, cioè più vicino alle strutture centrali dell’intelligenza.
Possiamo pensare a una diversificazione fra processi altamente specifici (e che la mente deve, attraverso l’esperienza ripetuta, automatizzare) e processi che continuano a richiedere un controllo mentale. La lettura strumentale è un processo specifico che richiede automatizzazione, la comprensione del testo è un processo generale che implica processi centrali. Allo stesso modo, in ambito matematico, il calcolo deve essere automatizzato, il problem solving richiede controllo.
Il quadro di riferimento che può rendere conto di queste diversità è illustrato in fig. 2. Il quadro non è altro che la applicazione del modello a cono dell’intelligenza al caso dei disturbi specifici dell’apprendimento. Questo modello ha la prerogativa di non considerare solo i disturbi specifici di apprendimento, relativi a lettura, matematica e scrittura (questi ultimi hanno una collocazione prossima ai disturbi di lettura), ma si occupa anche di disturbi (chiamati ‘non-verbali’ o ‘visuospaziali’) in cui il linguaggio ha un peso scarso.
Questi disturbi sono stati tradizionalmente trascurati perché la scuola insiste di solito sul linguaggio e, eventualmente, sui numeri, ma stanno cominciando finalmente a essere oggetto di attenzione, per le ripercussioni che possono avere non solo nel caso di particolari apprendimenti a base visuospaziale (certi aspetti della matematica, il disegno, ecc.), ma anche perché possono implicare notevoli risonanze emotive. Anche nel caso dei disturbi visuospaziali, benchè la cosa ancora non sia stata chiaramente esplicitata, possiamo pensare a una differenziazione fra difficoltà a livello di automatismi (che per esempio potrebbero riguardare le abilità grafiche) e difficoltà a livello di processi controllati (come nel caso della soluzione di problemi spaziali).
Dal modello illustrato in fig. 2 consegue dunque una classificazione dei DSA, che si basa sull’incrocio fra due dimensioni fondamentali e cioè: 1) il tipo di contenuto su cui la mente del bambino deve esercitarsi, 2) il grado di controllo richiesto alla mente. Le diverse abilità sono in differente relazione con le strutture intellettive centrali: il rapporto è più stretto con le abilità controllate. Il modello considera anche il caso di altre problematiche evolutive che comportano difficoltà di apprendimento, e cioè il ritardo mentale (disabilità intellettiva) e il disturbo di attenzione e iperattività (ADHD). Come si può vedere, questi due disturbi prescindono, in gran parte dal tipo di contenuto su cui la mente deve lavorare, e vanno ad interessare livelli a diversa centralità intellettiva. Il caso più devastante è sicuramente quello del ritardo mentale, ove sono proprio le struttura più centrali ad essere coinvolte, con implicazioni più pervasive su tutto il funzionamento della mente.
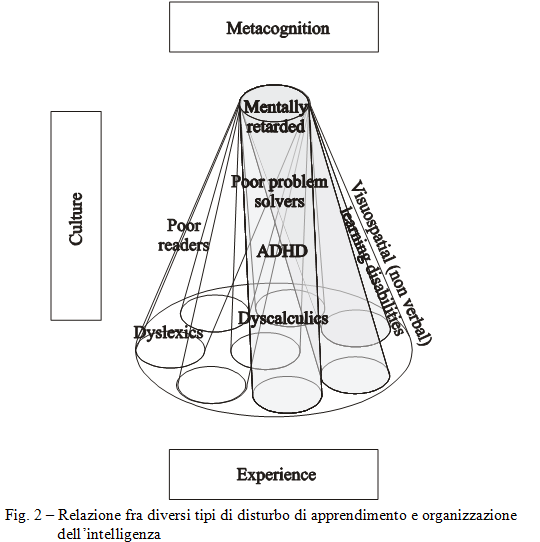
CESARE CORNOLDI
Nato a Cantello (VA) il 24/7/1947, residente a Padova, professore ordinario di Psicologia generale, Universita’ di Padova, si e’ laureato in Filosofia nel 1970, e’ stato dal 1972 presso l’Univ. di Padova come borsista, incaricato, e prof. Straordinario (dal 1982). È stato titolare di progetti collaborativi di ricerca con le Universita’ di North Carolina, Parigi, Aberdeen, Hull, Oslo e di un progetto CEE-Human Capital, oltre che di numerosi progetti CNR (di cui l’ultimo sulla multimedialita’), MURST (per sei anni coordinatore nazionale) e di altre Agenzie. È stato due volte direttore del Dipartimento di Psicologia Generale e più volte Presidente di diverse Associazioni Nazionali (SIPs-Ricerca di Base, CNIS, AIRIPA). È nel comitato editoriale di numerose riviste nazionali e internazionali. È autore di una decina di volumi, di cui tre in lingua inglese, e di circa 200 lavori di ricerca comparsi sulle maggiori riviste nazionali e internazionali. Fra i principali interessi di ricerca vi sono la memoria, l’apprendimento e i suoi disturbi. Presidente per gli anni 2003-2004 della European Society for Cognitive Psychology.